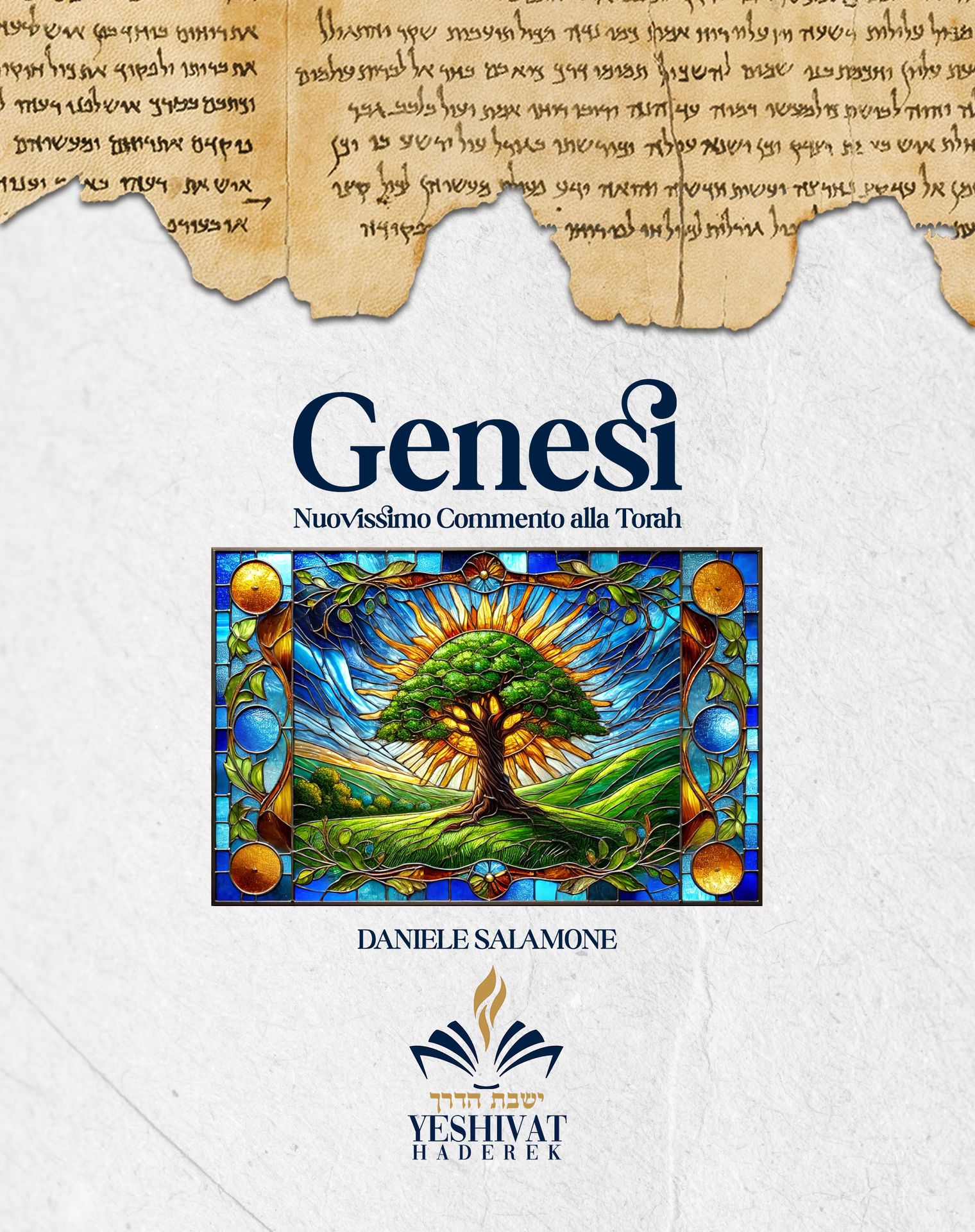Parashah (Genesi 25,19-34)
Introduzione
La parashah di Toledot narra della storia di Isacco e della sua discendenza, un racconto ricco di colpi di scena, inganni e scelte che potrebbero sembrare moralmente discutibili. Tuttavia, scavando più a fondo, scopriamo che dietro a queste azioni si cela un concetto più profondo: solo come un pozzo che nasconde l’acqua viva, ci sono lezioni spirituali da trarre, che si rivelano solo attraverso un'attenta riflessione.
Sterilità di Rebecca
La narrazione di Toledot si apre con la sterilità di Rebecca, un elemento che conferisce alla nascita dei suoi figli, Esaù e Giacobbe, una valenza teologica profonda, ponendo in luce la potenza e la fedeltà di Dio. La concezione di questi gemelli non è il frutto di un processo naturale o di un intervento umano, ma rappresenta l'attuazione del disegno divino, in quanto Dio porta a compimento la Sua promessa fatta ad Abraamo e alla sua discendenza. Isacco e Rebecca diventano, quindi, strumenti nelle mani di Dio, la cui fedeltà testimonia l’affidabilità di El Shadday (Colui che pronuncia le promesse), un titolo che sottolinea la Sua sovranità e la certezza dell'adempimento delle Sue parole.
L'oracolo: il destino di due popoli
Rebecca riceve un oracolo da YHHW che segnerà il destino dei suoi figli, Esaù e Giacobbe. Il messaggio divino, che preannuncia la nascita di due popoli separati, è cruciale per comprendere il piano di Dio, un piano che si rivelerà attraverso le scelte dei due gemelli. La dichiarazione
Uno dei due popoli sarà più forte dell'altro, e il maggiore servirà il minore (Gen. 25,23)
non è solo una profezia sulla loro discendenza, ma anche un’indicazione dell'inversione dei ruoli, che riflette un principio teologico fondamentale: il potere e il destino non sono determinati dalla nascita, ma dalla volontà di Dio.
L'antitesi di Esaù e Giacobbe
Nonostante la loro comune origine, Esaù e Giacobbe sono figure antitetiche, contrapposte tanto nei tratti caratteriali quanto nelle loro scelte di vita. Esaù, il cacciatore nomade, si distingue per la sua impulsività e il suo contatto con le popolazioni circostanti, evidenziando una vita esterna e incentrata sul presente. Al contrario, Giacobbe è descritto come un uomo che «vive nelle tende» (eufemismo che i rabbini collegano allo studio della Torah), alla riflessione e alla vita familiare. Queste caratteristiche sembrano già anticipare le scelte che i due fratelli faranno, con Esaù che non riconosce l'importanza della primogenitura e Giacobbe che, pur nella sua astuzia, sembra orientato a garantire la continuità della promessa divina.
La vendita della primogenitura: l'mpermanenza delle cose terrene
La scena della vendita della primogenitura (Gen. 25,32-33) è un episodio emblematico nella storia dei due fratelli. Esaù, sopraffatto dalla fame e dalla stanchezza, cede con troppa semplicità il suo diritto di primogenitura a Giacobbe per un piatto di minestra rossa (letteralmente «dammi questa rossa rossa»), un atto che evidenzia la sua incapacità di apprezzare il valore spirituale e simbolico della primogenitura. Questo diritto non è solo un privilegio ereditario, ma un simbolo sacro di continuità familiare e di adesione al piano divino. La cessione della primogenitura, in questo senso, rappresenta l'incapacità di Esaù di comprendere l'importanza di ciò che era stato a lui assegnato, ponendo così le basi per il destino divinamente orchestrato di Giacobbe.
Pertanto, la vendita della primogenitura non è un caso isolato della Bibbia, in quanto nei testi del Vicino Oriente antico (ANET) si parla di un uomo che barattò la sua eredità in cambio di una pecora!
Giacobbe, il "soppiantatore"
Il nome stesso di «Giacobbe», dall'ebraico יעקב (ya'aqov)che significa «colui che tiene il calcagno» (Gen. 25,26), riflette il suo ruolo di "soppiantatore", sempre pronto a prendere l'opportunità che gli si presenta. Sebbene l'inganno da lui perpetrato ai danni di Esaù possa apparire moralmente discutibile, la sua azione è indissolubilmente legata alla necessità di adempiere alla volontà di Dio. L'incapacità di Esaù di comprendere il valore della primogenitura e di assumersi la responsabilità spirituale fa sì che Giacobbe diventi il candidato più idoneo per portare avanti la discendenza promessa. Il piano divino si compie attraverso Giacobbe, pur nel contesto delle sue imperfezioni.
Lo scambio della benedizione
Un episodio centrale della parashah è lo scambio della benedizione (Gen. 27,1-45), architettato da Rebecca, che ascolta la conversazione tra Isacco ed Esaù e organizza l'inganno ai danni del marito. Sebbene Giacobbe sembri essere l'artefice di un inganno nei confronti di Isacco, il vecchio patriarca, cieco e ormai "prossimo" alla morte (anche se resterà vivo per altri 20 e più anni), la scena rivela un piano celeste che va oltre l’immediatezza delle azioni umane. Isacco, pur non conoscendo l'intero contesto, riconosce la fede di Giacobbe quando lo benedice (Eb. 11,20). Questo riconoscimento, nonostante la cecità fisica e spirituale che sembra accompagnare la figura di Isacco, segnala che Giacobbe era stato scelto per essere il canale attraverso il quale si sarebbero compiuti gli scopi divini. Il piano di YHWH, infatti, si manifesta anche attraverso le scelte e le azioni imperfette dei protagonisti.
Besorah (Ebrei 11,20; 12,16)
Fede e benessere spirituale
Per fede Isacco benedisse Giacobbe ed Esaù anche riguardo a cose future.
La porzione profetica di Ebrei offre una riflessione profonda sulla fede e sulla perseveranza, temi centrali nella storia di Giacobbe ed Esaù. In Eb. 11,20, si riporta di Isacco che «per fede» benedice Giacobbe ed Esaù, in un atto di fede che trascende la sua comprensione immediata. Questo gesto evidenzia la sua adesione al piano di YHWH, pur nel limite della sua visione umana.
e che nessuno sia fornicatore o profano, come Esaù, che per una sola pietanza vendette la sua primogenitura.
Al contrario, in Eb. 12,16, Esaù è descritto come «fornicatore e profano» per aver disprezzato il valore della primogenitura e per aver vissuto una vita superficiale. La sua incapacità di riconoscere ciò che era sacro lo rende indegno di ricevere la benedizione di Dio. Questo episodio ci insegna che la benedizione non può essere acquisita superficialmente, ma richiede un cuore che riconosce il valore della volontà di Dio e delle sue promesse.
La riflessione di Ebrei ci guida a comprendere come Dio agisca nei cuori, scrutando le intenzioni più intime. Sebbene le azioni di Giacobbe possano sembrare ingannevoli o imperfette, la sua fede è ciò che gli consente di essere scelto per portare avanti il piano divino. In modo simile, anche noi, pur nei nostri difetti, possiamo essere trasformati dalla fede in Yeshua, il Messia, che scruta il cuore e ci guida verso la benedizione eterna.
Conclusione
La Parashah di Toledot e la Besorah di Ebrei ci offrono una rivelazione cruciale: il piano di Dio, sebbene non sempre visibile agli occhi umani, si manifesta attraverso la fede. Le scelte di Giacobbe, pur tra ambiguità morali, sono segno di come la mano divina guidi gli eventi. Allo stesso modo, la Lettera agli Ebrei ci insegna che una fede autentica — che guarda oltre le apparenze — è ciò che ci consente di comprendere e partecipare al piano divino.
Ora, come Giacobbe ha saputo afferrare il diritto alla benedizione nonostante le sue imperfezioni, anche noi siamo chiamati a rispondere alla chiamata di Dio con fede. Non si tratta solo di un diritto, ma di un dono che trasforma profondamente la nostra natura, affinché possiamo divenire partecipi della Sua gloria in Yeshua, il Messia.
Questo è il momento di rispondere alla chiamata di Dio: di mettere da parte le apparenze e di afferrare con fede la promessa che Dio ha preparato per noi. Unisciti a questo cammino di trasformazione, lasciandoti guidare dalla fede che vede oltre, e scopri la benedizione che Dio ha riservato per coloro che si affidano al Suo piano eterno.
Guarda la parashah del moreh (26/11/2022)
Per approfondire questa parashah, si consiglia la lettura del Nuovissimo Commento alla Torah dedicato al Genesi.