Introduzione
Poche pagine delle Scritture Apostoliche hanno generato discussioni tanto vivaci quanto l’apparente paradosso tra gli apostoli Paolo e Giacomo. Il primo proclama la giustificazione per fede «indipendentemente dalle opere della legge» (Rom. 3,28; Gal. 2,16), il secondo afferma che «l’uomo è giustificato per opere e non per fede soltanto» (Giac. 2,24). Se isolate dal loro contesto, queste frasi sembrano smentirsi a vicenda. Ma le Scritture non si smentiscono: è il lettore frettoloso che spesso oppone ciò che il testo armonizza.
Il punto d’avvio è semplice: Paolo e Giacomo rispondono a problemi diversi con lessici che si sovrappongono solo in parte.
- Paolo argina il legalismo e il merito religioso e difende la causa della giustificazione;
- Giacomo smaschera l’ipocrisia di una “fede” che resta sterilee ne rivendica l'evidenza.
La contraddizione, dunque, è solo apparente. In questo articolo mostrerò che in Giacomo il verbo «giustificare» assume una funzione evidenziale o vindicativa — «rendere manifesto che» — e non forense-fondativa come in Paolo, e che le opere attestano la fede resa viva dalla grazia (Ef. 2,8-10; Tt. 2,11-14). Ne consegue la tesi: la “giustificazione per opere” in Giacomo è subordinata e dipendente dalla giustificazione per fede in Paolo; le opere sono frutto necessario, non requisito meritorio.
Chiarificazione terminologica e filologica
I fraintendimenti si sciolgono a partire dal linguaggio. «Fede» traduce il greco pistis, termine che nelle Scritture Apostoliche non indica soltanto l’assenso intellettuale, ma la fiducia leale, l’affidamento personale al Messia e alla Sua promessa, il cui frutto è obbedienza (Rom. 1,5). «Opere» rende il greco erga, parola neutra che designa azioni in genere: ciò che conta è l’aggettivo o il contesto. Paolo distingue con cura tra «opere della legge» — pratiche identitarie e prestazioni legali legate al nomos/Torah come sistema di appartenenza (Gal. 2–3) — e le opere buone preparate da Dio perché il credente cammini in esse (Ef. 2,10). Le prime non giustificano; le seconde sono il frutto della salvezza.
Cruciale è anche dikaioō, «giustificare». In Paolo, soprattutto in Rom. 3–4, il verbo ha valore forense: Dio dichiara giusto il peccatore per la fede nel Messia, imputandogli la giustizia del Messia (Rom. 3,21-26; 4,1-8; Flp. 3,9). Il suo esempio chiave è Abrasmo: «Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia» (Gen. 15,6; Rom. 4,3). In Giacomo, la stessa figura è riletta sul piano della manifestazione storica: l’offerta di Isacco (Gen. 22) rende visibile e compiuta quella fede (Giac. 2,21-24). In altri termini,
- Paolo guarda a Gen. 15,6 (la giustizia creditata),
- Giacomo a Gen. 22 (la fede che si vede).
Non due "Vangeli diversi", ma due tempi dell’unico Vangelo: fondazione e verifica.
Questa distinzione non è un artificio. La polisemia di dikaioō è attestata già nel greco comune: può significare «dichiarare giusto» o «dimostrare giusto». Nel primo senso, la giustificazione è atto gratuito di Dio; nel secondo, è l’attestazione visibile della realtà già compiuta. Giacomo — che combatte un “fideismo” senza frutti e opere come praticato dai credenti nel vangelo a buon mercato e nell'ipergrazia — privilegia il secondo uso. Paolo — che confuta il merito — insiste sul primo.
Paolo: giustificazione per fede e teleologia delle opere
Il cuore dell’annuncio paolino pulsa in Rom. 3,21-26:
Ora, indipendentemente dalla Torah, è stata manifestata la giustizia di Dio [...] mediante la fede in Yeshua Messia, per tutti quelli che credono (Rom. 3,21-22)
La giustificazione è dono, non salario (Rom. 4,4-5); non procede dalla «legge delle opere», ma dalla «legge della fede» (3,27-28). Paolo è altrettanto netto in Galati:
Sappiamo che l’uomo non è giustificato per le opere della Torah ma soltanto per mezzo della fede in Yeshua Messia (Gal. 2,16; cfr. 3,6-14)
Da qui l’esito:
Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio (Rom. 5,1)
Eppure, lo stesso Paolo lega inscindibilmente la giustificazione alla trasformazione. L’elogio della gratuità in Ef. 2,8-9 è cucito al v. 10:
Siamo opera Sua, creati nel Messia Yeshua per le buone opere, che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo (Ef. 2,10)
La priorità è logica e cronologica: prima la nuova creazione, poi il cammino nelle opere. È la teleologia delle opere: non causa, ma scopo. In Tito, la grazia che salva «ci insegna a rinunciare all’empietà» (Tt. 2,11-12) e rende il popolo «zelante nelle opere buone» (2,14).
Alister McGrath, in Iustitia Dei, ha mostrato come la dottrina paolina sia insieme forense e relazionale: la giustizia imputata introduce il credente in una nuova relazione di figliolanza, da cui scaturisce una vita conforme (Rom. 8,1-4). Thomas R. Schreiner insiste che la giustificazione è «verdetto escatologico anticipato» dichiarato ora sul fondamento di Yeshua, e che le opere attestano la realtà di quella fede nel giudizio finale senza costituirne il merito. John Stott e J.I. Packer, in chiave pastorale, ribadiscono che la fede che giustifica non resta sola: «la fede sola giustifica, ma la fede che giustifica non rimane sola» — un modo semplice per tenere insieme Romani ed Efesini. Michael Horton, da parte sua, chiarisce che confondere mezzo e frutto — fede e opere — mina la gratuità del Vangelo e, paradossalmente, anche l’etica cristiana: se tutto è merito, nulla è gratitudine.
Sul piano storico, N.T. Wright ricorda che «opere della legge» in Galati e Romani includono i markers identitari (circoncisione, kasherut, calendario) e l’intero regime della Torah come badge di appartenenza. Senza appiattire Paolo sul “nomismo dell’alleanza”, questa cornice aiuta a capire perché la giustificazione, per lui, non può dipendere da performances: essa crea un popolo nuovo al di là dei confini etnici, «né giudeo né greco» (Gal. 3,28).
Giacomo: la fede viva è operosa (e perciò “giustifica” nel senso che si vede)
Giac. 2,14-26 non è una polemica contro Paolo, che probabilmente egli neppure ha davanti in forma scritta, ma contro una caricatura della fede: parole senza opere, professione senza prassi.
A che serve, fratelli miei, se uno dice d’aver fede ma non ha opere? Può la fede salvarlo? (2,14)
L’esempio del fratello nudo e affamato smonta il nominalismo religioso (2,15-16). «Così anche la fede, se non ha opere, è morta in se stessa» (2,17). La metafora finale è cruda: «Come il corpo senza spirito è morto, così anche la fede senza le opere è morta» (2,26).
Qui l’immagine biblica si carica di una risonanza del Tanakh: il cadavere contamina (Num. 19). Una “fede-cadavere” non è neutra; è impura, incapace di comunione. Per questo Giacomo convoca Abraamo e Rahab come casi di studio: la fiducia di Abraamo in Gen. 15,6 diventa storicamente verificabile nell’obbedienza di Gen. 22 (Giac. 2,21-23); la fede di Rahab si mostra nell’accoglienza dei messaggeri (2,25). Quando dice che Abraamo «fu giustificato per opere» (2,21), Giacomo intende: fu mostrato giusto, si vide ciò che Dio aveva già dichiarato. Il v. 22 è chiave: «La fede agiva insieme alle sue opere e per le opere la fede fu resa perfetta» — compiuta, portata a maturità.
L’armonia con Paolo emerge allora con chiarezza:
- Paolo combatte il merito;
- Giacomo combatte l’ipocrisia.
Stesso Vangelo, due bersagli diversi.
- Paolo fonda;
- Giacomo verifica.
E Yeshua? «Dai loro frutti li riconoscerete» (Mt. 7,16-20). Giovanni è sulla stessa linea: «Chi dice: “Io l’ho conosciuto”, e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo» (1 Giov. 2,3-6). E la parabola della vite e dei tralci mostra che la comunione con il Messia (fede) si esprime inevitabilmente in frutto (opere) (Giov. 15,1-8).
Coerenza logica, ermeneutica e filologica
L’idea che «Paolo e Giacomo si contraddicono» è una tesi fai-da-te illogica, antibiblica e filologicamente fragile.
- Illogica, perché confonde causa e segno: che il frutto non sia radice non implica che l’albero sia vivo senza frutto. Anzi, senza di esso è inutile, viene sradicato e gettato alle fiamme.
- Antibiblica, perché ignora l’unità della rivelazione: il Dio che giustifica gratuitamente è lo stesso che santifica efficacemente (Rom. 8,1-4).
- Filologicamente debole, perché appiattisce dikaioō su un unico e solo significato e tratta erga come categoria monolitica.
Tre analogie smascherano l’assurdo.
- L’albero-frutto: negare i frutti perché «non sono la radice» equivale a dichiarare vivo un albero senza linfa visibile (Mt. 7,16-20).
- Respiro-vita: dire «sono vivo ma non respiro» è come dire «ho fede ma non opere» (Giac. 2,17.26).
- Fuoco-luce: se il fuoco (fede) non produce luce e calore (opere), che fuoco è? (Giov. 15,1-8; 1 Giov. 2,3-6).
In chiave sistematica, Paul Tillich ha descritto la giustificazione come «accettazione dell’inaccettabile»: un atto che crea identità nuova. Ma, come nota Wolfhart Pannenberg, l’identità si manifesta storicamente: la giustificazione è dichiarazione presente con esito escatologico, e la vita rinnovata ne è segno anticipatore. McGrath, ancora, chiarisce che la “giustizia aliena” imputata non resta esterna: per lo Spirito, la comunione con il Messia produce conformità (Rom. 8,29). È esattamente ciò che Giacomo chiede di vedere.
Le opere nel pensiero cattolico e il consenso reale possibile
Per onestà teologica, occorre evitare caricature dell’altra sponda. Il Concilio di Trento (Sessione VI, De iustificatione) rifiuta esplicitamente il merito pelagiano. La grazia è preveniente: Dio muove il cuore, e l’uomo coopera realmente, ma come figlio adottato, non come salariato. Il Catechismo della Chiesa Cattolica (§§1996-2011) parla di merito «in senso filiale»: la grazia non annulla la responsabilità, la fonda; e le «opere buone» sono frutti della grazia. La Dichiarazione congiunta luterano-cattolica sulla dottrina della giustificazione (1999) ha riconosciuto un consistente consenso:
Siamo accettati da Dio e riceviamo lo Spirito Santo, che rinnova i cuori, chiamandoci e rendendoci capaci di opere buone.
Questo terreno comune non cancella differenze reali, ma permette di dire con chiarezza apologetica che la Bibbia non insegna la salvezza per merito: insegna una grazia efficace che genera obbedienza. Qui Paolo e Giacomo si danno la mano: giustificazione gratuita (Rom. 3,24; Ef. 2,8-9) e fede che opera per mezzo dell’amore (Gal. 5,6).
Il “mito” della salvezza per opere nel Tanakh
Si sente spesso ripetere che «nell’Antico Testamento si era salvati per le opere della legge». È un mito, uno stereotipo, una leggenda metropolitana. Ci credevano solo i Farisei! Nel Tanakh, l’alleanza mosaica istituisce un binario reale di benedizioni e maledizioni temporali legate all’obbedienza (Deut. 28): la fedeltà alla Torah comporta prosperità nella terra; l’infedeltà, giudizio storico. Ma quando si parla di giustizia davanti a Dio, la voce è un’altra: «Beato l’uomo a cui la trasgressione è rimessa, a cui il peccato è coperto» (Sal. 32,1-2); «il giusto vivrà per la sua fede» (Aba. 2,4). È per questo che Paolo sceglie Abraamo come paradigma: «credette a Dio» prima della circoncisione, e la fede gli fu accreditata a giustizia (Gen. 15,6; Rom. 4,1-8). Isaia invita al «comprare senza denaro» (Is. 55): grazia, non salario.
Collocare Paolo sullo sfondo del «nomismo dell’alleanza» (E.P. Sanders) e delle letture storiche proposte da N.T. Wright può essere utile, purché non si appiattisca il suo messaggio: l’appartenenza al popolo di Dio è rinnovata e allargata nel Messia Yeshua, ma la modalità della giustificazione resta gratuitamente fondativa, non cooperativa quanto alla causa. In ogni caso, la linea biblica è univoca: la giustizia è dono ricevuto con la fede; l’obbedienza è il cammino (nonché il frutto) di chi è stato già salvato.
Implicazioni pastorali e apologetiche
Se Paolo e Giacomo convergono, allora “l'alternativa” «sola fede contro opere» è un falso dilemma. Ef. 2,8-10 tiene insieme dono e cammino: «per grazia [...] mediante la fede» (2,8-9) e «per le opere [...] preparate» (2,10). Difendere l’unità biblica significa affermare con Paolo che Dio giustifica i peccatori per grazia mediante la fede nel Messia (Rom. 3,21-28; 5,1; Gal. 2,16; Flp. 3,9) e, con Giacomo, che questa fede si vede (Giac. 2,14-26).
La tesi “fai-da-te” della contraddizione si rivela anti-ermeneutica: ignora autore, pubblico, scopo e genere. È anche antipastorale: offre una “evangelicalità” disincarnata, fatta di parole senza discepolato. Yeshua, invece, non separa mai confessare e fare:
Non chiunque mi dice: “Kyrios, Kyrios”, entrerà nel Regno [...] ma chi fa la volontà del Padre Mio (Mt. 7,21-23)
I segni concreti del frutto sono noti: fede che opera per mezzo dell’amore (Gal. 5,6), carattere forgiato dallo Spirito (5,22-23), «visita agli orfani e alle vedove» e «conservare se stessi puri dal mondo» (Giac. 1,27). Non come prezzo, ma come profumo di una vita nuova.
Qui torna utile Packer: la giustificazione è il «verdetto del giudice che diventa l’abbraccio del Padre». E proprio perché è l’abbraccio del Padre, essa genera figli che somigliano al Figlio. Tillich direbbe che l’accettazione incondizionata scioglie l’ansia del merito; Pannenberg aggiungerebbe che il futuro del Regno rovescia nel presente la sua energia: la santificazione è la forma storica della giustizia ricevuta. E McGrath, di nuovo, ricorda che la Riforma non inventa una novità ma riscopre la trama scritturistica per cui «Dio giustifica l’empio» (Rom. 4,5) e poi lo conforma all’immagine del Figlio (8,29).
Conclusione
Non posso accontentarmi di una fede pronunciata a voce. Se la mia fede non respira nell’obbedienza, è un corpo senza spirito: impuro, incapace di comunione (Giac. 2,26; Num. 19). Confesso con Paolo che sono stato dichiarato giusto «per fede» (Rom. 5,1), indipendentemente dalle «opere della Torah» (3,28; Gal. 2,16); ma so, con Giacomo, che quella fede si rende visibile nel quotidiano. Il Messia non mi ha salvato per lasciarmi com’ero: «la grazia di Dio salvifica [...] mi educa» (Tt. 2,11-12) e mi rende «zelante nelle opere buone» (Tt. 2,14). Per questo difendo senza esitazioni la priorità di Paolo e la concretezza di Giacomo: la prima fonda, la seconda verifica.
Non vedo alcun conflitto, ma un’unica sinfonia: il Dio che mi giustifica è il Dio che mi santifica; ciò che la croce dona, lo Spirito rende visibile (Rom. 8,1-4). E allora scelgo l’albero che porta frutto (Mt. 7,16-20), il tralcio che rimane nella vite (Giov. 15,1-8), la fede che cammina nella luce e osserva i comandamenti (1 Giov. 2,3-6). Non per guadagnare la grazia — sarebbe contraddire il Vangelo — ma perché la grazia mi ha già afferrato. «Il giusto vivrà per la sua fede» (Aba. 2,4), e quella vita, respirando, si vede.
Lettura consigliata
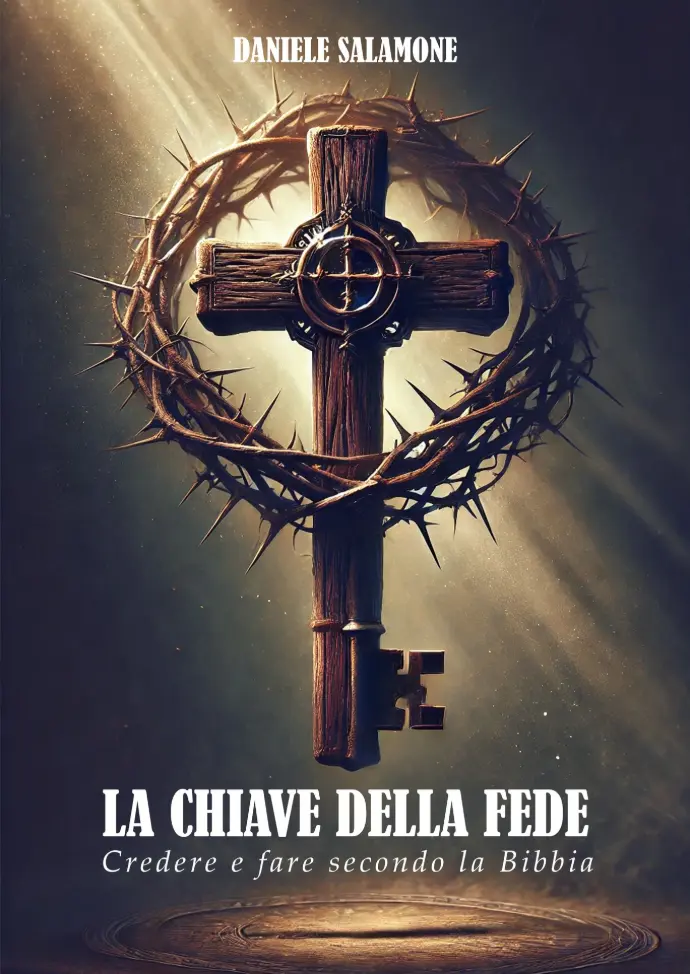
La Chiave della Fede
La salvezza, secondo le Scritture, non si ottiene attraverso meriti personali o osservanze legali, ma è dono gratuito di Dio, reso accessibile per grazia mediante la fede in Yeshua. Questa fede, però, non deve rimanere mai sterile: genera una vita nuova, trasformata e orientata all’amore, alla giustizia e alla misericordia.
Le opere non sono la causa della giustificazione, ma il segno visibile che la grazia ha operato nel cuore. Così la libertà dalla legge diventa chiamata a vivere nella pienezza dello Spirito.