Introduzione
Nel lessico quotidiano siamo abituati a concepire il dono come un regalo: qualcosa che, una volta consegnato, diventa proprietà esclusiva di chi lo riceve. Nel contesto biblico e teologico, però, il concetto di dono spirituale ha un significato ben più elevato e peculiare. Non si tratta di un “regalo” nel senso comune — come un marito che regala un mazzo di fiori alla moglie, o un padre regala l'automobile al figlio — ma piuttosto di una concessione di grazia da parte di Dio. Un dono spirituale è un’elargizione gratuita dello Spirito Santo, data all’uomo non perché ne diventi padrone asssoluto, ma perché possa esserne strumento nel momento opportuno e per uno scopo ben preciso.
Questa differenza di prospettiva è cruciale. Quando Dio elargisce i doni spirituali, specialmente quelli carismatici, non sta conferendo “superpoteri” all’uomo rendendolo un super-uomo capace di dominare sul dono e usarlo a proprio piacimento. Al contrario, i doni dello Spirito rimangono sempre proprietà di Dio, che li concede sovranamente «a ciascuno [...] come vuole». Essi sono manifestazioni della grazia divina, destinate al servizio e all’utilità comune, non all’esaltazione individuale. La manifestazione dello Spirito non è mai fine a sé stessa, ma avviene solo con uno scopo utile: se non vi è uno scopo secondo la volontà di Dio, lo Spirito Santo semplicemente non elargisce né manifesta un dono.
Il significato biblico di “dono spirituale”
Per comprendere appieno la natura dei doni spirituali, è utile partire dal termine originale impiegato nelle Scritture Apostoliche. La parola greca normalmente tradotta «dono» in questi contesti è chàrisma, derivata da cháris che significa «grazia». Letteralmente, dunque, chàrisma indica un «dono di grazia», ovvero un’elargizione gratuita da parte di Dio. Il suffisso -ma di charis in greco suggerisce il risultato concreto di un’azione; chàris-ma può quindi essere inteso come la manifestazione concreta della grazia divina nella vita di una persona. In altre parole, un dono spirituale è l’espressione visibile della grazia e della potenza di Dio che opera in una persona e attraverso di essa.
Nelle Scritture Apostoliche — in particolare nelle lettere di Paolo — troviamo l’insegnamento più sistematico sui doni spirituali o carismi. Paolo utilizza il termine chàrisma sia in senso ampio, riferendosi ad ogni dono gratuito di Dio (incluso il dono della salvezza; cfr. Rom. 6:23), sia in senso più stretto per indicare quelle capacità spirituali straordinarie concesse ai credenti per l’edificazione della Kehillah. Le principali liste di doni spirituali compaiono in Rom. 12,6-8; 1 Cor. 12,7-11.28-30, e comprendono una varietà ampia di manifestazioni: dalla profezia all’insegnamento, dalla guarigione al parlare in lingue straniere, dalla parola di sapienza alla fede straordinaria, fino al discernimento degli spiriti, alle opere di misericordia e così via. Questa molteplicità di carismi suggerisce che essi non costituiscono un elenco chiuso o statico: i doni dello Spirito sono “vari e multiformi” e in numero potenzialmente indefinito, poiché lo Spirito li distribuisce in base alle necessità concrete del Corpo del Messia.
Due principi fondamentali emergono dall’insegnamento biblico sui carismi.
- Lo Spirito Santo è l’unico sovrano donatore: è Lui che decide quale dono concedere, a chi e quando. Paolo lo afferma chiaramente: «tutte queste cose le opera quell’unico e medesimo Spirito, distribuendo i doni a ciascuno in particolare come vuole». I carismi non scaturiscono dallo sforzo o dal merito umano, né possono essere generati a volontà da una persona; sono, per definizione, grazie elargite liberamente da Dio secondo il Suo insindacabile e imprevedibile volere.
- I doni sono orientati all’edificazione della Kehillah: non vengono dati per uno scopo privato o per il prestigio spirituale dell’individuo, ma per il bene comune. «A ciascuno è data la manifestazione dello Spirito per il bene comune», ricorda Paolo. Questo significa che la finalità ultima di ogni carisma è di contribuire, in modo concreto e spirituale, alla crescita, all’unità e alla santificazione della comunità dei credenti.
Già da queste basi bibliche possiamo intravedere come il concetto di dono spirituale si distingua dalla nozione corrente di regalo. Mentre un regalo ordinario diventa proprietà personale ed esclusiva del ricevente, il dono spirituale resta proprietà di Dio e rimane sotto la Sua Signoria. Esso è concesso al credente non come un trofeo da esibire o un potere da esercitare arbitrariamente, ma come un incarico, una funzione da svolgere nel Corpo del Messia. In effetti, la Scrittura parla dei credenti come «amministratori» dei doni di Dio:
ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri, come buoni amministratori della multiforme grazia di Dio (1 Pt. 4,10)
Qui l’apostolo Pietro sottolinea che ogni dono è parte di una multiforme grazia divina di cui siamo dispensatori responsabili. Non siamo proprietari assoluti, ma piuttosto depositari fedeli di qualcosa che appartiene a Dio e che Egli ci chiama a usare saggiamente per gli altri.
Dono come bene affidato o trasferito?
Chiarito il contesto biblico generale, approfondiamo la differenza tra dono spirituale e regalo in termini di proprietà e controllo. Nell’esperienza comune, fare un regalo implica trasferire definitivamente un oggetto a qualcun altro: chi dona rinuncia al possesso, e chi riceve ne acquisisce la proprietà esclusiva. Un concetto simile era speculativamente sostenuto dai saggi del Talmud (Temurah 16a:3; Bava Betzia 59b:5), i quali, interpretando il brano deuteronomico «[la Torah] non è nel cielo» (Deut. 30,11-14), hanno sostenuto che Dio ha donato la Torah come proprietà di Israele, e quindi Dio ha cessato di avere autorità sulla Sua stessa Parola perché l'ha regalata ai saggi (cfr. R' Yosef Albo, Sèfer Ha-‘Ikkarìm III, 23; R' Binyamin Hakohen Vitale, Avòt ‘Olàm ai Pirkè Avòt). Se applicassimo questa idea già molto antica ai doni spirituali, dovremmo pensare che Dio “ceda” all’uomo un potere o una capacità, che da quel momento l’uomo può gestire a proprio arbitrio. Questa concezione è fuorviante e non trova riscontro nella Bibbia, ma solo nelle pretese rabbiniche di ieri e in quelle neo-pentecostali di oggi.
In realtà, i doni dello Spirito Santo non sono una proprietà personale del credente (così come neanche la Torah!), né una proprietà della Chiesa istituzionale; essi restano sempre di Dio, che li concede in fiducia.
I doni non servono per vantarci o per dominare o per sentirci maggiori degli altri, servono invece per ministrare il Corpo del Messia, la Kehillah.
In altre parole, il dono spirituale non eleva chi lo riceve a un rango superiore, né gli fornisce uno strumento di dominio. Non lo fa diventare "capo", al contrario, impone su di lui una responsabilità che lo fa diventare servo! I credenti sono chiamati a esercitare i carismi ricevuti con umiltà e amore, consapevoli che si tratta di risorse date in prestito da Dio per il beneficio altrui, e che Dio si riprende quando vuole per darli ad altri.
Un chiaro richiamo a questa responsabilità lo troviamo, come accennato, in 1 Pt. 4,10. Ogni dono, ci dice Pietro, è un appello a mettersi a servizio della comunità: lo hai ricevuto non perché te ne pavoneggiassi, ma come un bene affidatoti perché lo amministrassi con saggezza. Non appartiene a te, ma a Dio che te lo ha concesso perché tu possa contribuire all’incremento dell’intero corpo ecclesiale. Un dono, quindi, da accogliere con riconoscenza e da gestire con umiltà e responsabilità. Il carisma, quindi, è un bene affidato (non ceduto) e Dio rimane il proprietario ultimo. L’uomo lo riceve in custodia, per metterlo a frutto al servizio dei fratelli, e dovrà rendere conto a Dio di come l’avrà utilizzato.
Solo in pochissimi ambienti pentecostali, dove forte è l’accento sull’attualità dei doni spirituali, si ribadisce che essi non sono mai una proprietà di cui gloriarsi. Non è una proprietà personale: il Dono dello Spirito Santo viene affidato al credente, che è responsabile davanti a Dio del modo col quale lo amministra. Servirsi di un dono per esaltare sé stessi contraddice la volontà di Dio. Questa prospettiva rovescia la logica del regalo: il dono spirituale non diventa mai “mio” in senso proprietario, piuttosto io divento “Suo” — dello Spirito — nel senso che mi metto a disposizione dell’azione di Dio. È il credente che si lascia “possedere” dallo Spirito, non il contrario.
In termini giuridici moderni, potremmo paragonare i carismi non a una proprietà privata, bensì a un bene in usufrutto o amministrazione fiduciaria. Dio ne resta il titolare, mentre al credente è concesso di usarlo per un fine stabilito, secondo le direttive del proprietario. Questa differenza di status elimina sul nascere ogni idea di diritto sull’uso del dono: nessuno può vantare un carisma come un titolo di merito personale o pretenderne l’operatività al di fuori della volontà di Dio. La gratuità del dono spirituale, quindi, non va intesa nel senso che “Dio ce lo regala e noi ne disponiamo liberamente da padroni”, ma nel senso che ci è dato per grazia, senza nostro merito, affinché gratuitamente lo ridoniamo in servizio agli altri. «Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date» (Mt. 10,8) è il principio che Yeshua stesso enuncia ai discepoli nell’inviarli a ministero: pur riferendosi principalmente al dono della salvezza e della guarigione, il principio vale per ogni cosa spirituale ricevuta dalla bontà divina.
Per smascherare ulteriormente l’idea errata del dono inteso come possesso magico, può aiutarci il noto episodio di Simon Mago in Atti 8: Simon, un mago samaritano convertitosi esteriormente, vedendo che gli apostoli comunicavano lo Spirito Santo con l’imposizione delle mani, offrì loro del denaro dicendo:
Date anche a me questo potere, affinché colui al quale imporrò le mani riceva lo Spirito Santo (8,19)
Egli trattò il potere dello Spirito come una merce acquistabile, una sorta di oggetto da possedere. La reazione di Pietro fu durissima, l'anatema:
Il tuo denaro vada con te in perdizione, poiché hai pensato di ottenere col denaro il dono di Dio (8,20)
Pietro lo ammonì che non aveva né parte né sorte in quella cosa, perché il suo cuore non era retto davanti a Dio (v. 21). In poche parole, chi mercifica i doni spirituali o pensa di prendere possesso della potenza Spirito Santo, va all'inferno! Simone pensò che lo Spirito Santo non fosse altro che un potere da poter comprare o vendere. Voleva controllare l’opera dello Spirito Santo, considerandolo una forza di cui poteva disporre a suo piacimento, invece di una Persona che governava la sua vita. Simone voleva fare del dono di Dio un proprio “strumento magico”, invertendo i ruoli – l’uomo al controllo e lo Spirito Santo strumentalizzato. La risposta apostolica ristabilisce l’ordine: i doni di Dio non si comprano né si vendono, e non sono soggetti al controllo umano; si ricevono gratuitamente da Lui mediante la fede, e restano sotto la Sua autorità. L’episodio di Simon Mago è diventato emblematico al punto che “Simonìa” indica il peccato di mercificare le realtà spirituali. Esso ci ammonisce che concepire il dono spirituale come proprietà personale o mezzo di potere è non solo sbagliato, ma pericolosamente blasfemo e con conseguenze di perdizione.
In sintesi, dono spirituale ≠ regalo privatistico. Mentre il regalo comune passa di mano e finisce sotto il controllo del ricevente, il dono spirituale rimane saldamente sotto il controllo di Dio. Egli lo affida temporaneamente all’uomo perché lo utilizzi nell’ambito del servizio cristiano, e se ne riappropria quando e come vuole. Questa verità teologica dovrebbe instillare nel credente umiltà, tremore e gratitudine. Umiltà, sapendo che ogni capacità straordinaria è di Dio e non nostra; tremore, sapendo che dovremo rispondere dell’uso di ciò che appartiene al Signore; gratitudine, perché tutto è grazia immeritata.
La sovranità dello Spirito e il carattere temporaneo dei carismi
Un altro aspetto centrale dei doni spirituali, spesso frainteso, riguarda la loro modalità di manifestazione nel tempo. Come abbiamo visto, i carismi non sono “poteri” stabili posseduti dal credente a piacimento, ma interventi sovrani dello Spirito Santo che si manifestano quando Egli lo ritiene opportuno. La Scrittura e l’esperienza della Kehillah primitiva mostrano che i doni sono concessi “al bisogno”, in funzione di specifiche circostanze e necessità.
Paolo, dopo aver elencato vari carismi ai Corinzi, ribadisce:
tutte queste cose è l’unico e medesimo Spirito che le opera, distribuendole a ciascuno in particolare come Eegli vuole.
L’espressione «come Egli vuole» indica chiaramente che la volontà dello Spirito è decisiva tanto nell’assegnare un tipo di dono, quanto nel determinarne il momento e la modalità di operatività. Il credente non può attivare a comando un dono spirituale indipendentemente dallo Spirito di Dio: per esempio, se fosse autentico non si dovrebbe controllare né il parlare né il pregare in lingue. L'individuo può, certamente, predisporre sé stesso in fede e ubbidienza, può «desiderare ardentemente» i doni maggiori (1 Cor. 12,31) ed essere disponibile all’uso da parte di Dio, ma l’iniziativa ultima spetta sempre allo Spirito. Non esiste un carisma “automatico” o utilizzabile a discrezione umana, come se fosse un talento naturale. Anche quando diciamo colloquialmente che una persona “ha” un certo dono (di profezia, di guarigione, ecc.), dovremmo intendere propriamente che quella persona è usata frequentemente o meno frequentemente dallo Spirito in quel particolare carisma, a motivo della chiamata di Dio e della fedele disponibilità del credente. Ma non significa che il dono risieda in maniera autonoma e permanente nella persona.
Un esempio utile è il dono di guarigioni. Se a un credente è concesso il carisma di guarigione, ciò non implica che egli detenga un potere di guarire chiunque, in qualsiasi momento a suo piacimento: se così fosse, sarebbe buono recarsi negli ospedali e svuotarli! Significa piuttosto che, quando Dio vuole operare una guarigione miracolosa attraverso la preghiera, con la finalità di essere glorificato, spesso si servirà di quella o quell'altra persona come strumento. Ci possono essere occasioni in cui anche il più consacrato tra coloro che pregano per i malati non vede alcuna guarigione, perché la guarigione non dipende dalla sua potestà, ma dalla volontà sovrana di Dio. Persino l’apostolo Paolo, che pure fu canale di straordinari miracoli, non poté guarire la sua «spina nella carne» né rimuovere infermità di suoi collaboratori come Trofimo (2 Cor. 12,7-9; 2 Tim. 4,20), segno che quei doni si esercitavano solo quando Dio intendeva concederli.
La natura estemporanea di molti carismi è confermata anche dalla definizione di alcuni di essi. Prendiamo il caso della parola di sapienza. Questa non coincide con la sapienza acquisita o il bagaglio di esperienza di una persona; non significa che chi la esercita diventi improvvisamente “onnisciente” o possegga permanentemente tutta la sapienza divina. Si tratta piuttosto, come indica il termine stesso, di una parola specifica di saggezza soprannaturale data dallo Spirito in un momento preciso per risolvere una situazione o dare una direzione. Dunque il credente non possiede la sapienza di Dio in modo costante, ma può ricevere in quell’ora e per quel dato momento la porzione di sapienza necessaria, direttamente dall’alto, per affrontare una circostanza. Ciò realizza la promessa di Yeshua:
Non preoccupatevi di come o cosa risponderete, perché lo Spirito Santo vi insegnerà in quel momento ciò che dovrete dire (Lc. 12,11-12)
La soprannaturalità del dono non sta nel "prepararsi a dire la cosa giusta", ma affidarsi allo Spirito Santo che nel momento opportuno ci farà Egli stesso dire la cosa giusta. Analogamente, il dono di conoscenza è una rivelazione circoscritta (una singola informazione nascosta rivelata da Dio in tempo reale), non una scienza infusa permanente; il dono di fede è un’ondata speciale di fede per compiere un’opera straordinaria in un certo frangente, non necessariamente un livello di fede costante uguale per sempre.
Questa caratteristica “puntuale” dei carismi corrisponde al modo in cui il libero agire di Dio accompagna la Kehillah. Nella storia biblica vediamo che Dio suscita doni e miracoli quando servono e mai per intrattenere un pubblico: per esempio, nel libro degli Atti, di volta in volta lo Spirito spinge i discepoli a profetare, a parlare in lingue, a guarire i malati, ma sempre con un fine preciso (confermare la Parola predicata, aprire una porta al Vangelo, edificare i credenti, ecc.). La Kehillah primitiva sapeva che «lo Spirito Santo distribuisce i Suoi doni con totale sovranità secondo il suo volere» e proprio così Dio costituisce i vari ministeri necessari per il perfezionamento dei santi e l’edificazione del Corpo del Messia. I credenti dunque vivevano nell’attesa fiduciosa e nella preghiera, pronti a essere usati dallo Spirito, ma consci che l’iniziativa era Sua.
Un classico principio teologico insegna che i carismi autentici sono dinamici e legati al kairòs, cioè al tempo opportuno di Dio. Non a caso i carismi nella Kehillah si determinano in base a due principi: lo Spirito Santo, che è il donatore, e la Kehillah da edificare nella sua concretezza di tempo e di luogo. Ciò significa che lo Spirito può suscitare forme di dono modellate sulle necessità di una certa epoca o contesto, sempre per edificare la Kehillah. Egli agisce sempre in conformità alla Parola e non assegna a un individuo un potere irrevocabile: è sempre il Signore vivo e attivo, che guida e provvede secondo i bisogni reali. In ogni generazione, pertanto, i credenti sono chiamati a discernere i doni autentici (1 Cor. 12,10b parla del «discernimento degli spiriti» anche in tal senso) e a non spegnere lo Spirito (1 Tess. 5,19-21), restando aperti a come Egli vuole operare. Ma al contempo devono ricordare che i doni non operano a comando umano: si invocano con fede, non si pretendono con arroganza.
Questa prospettiva scoraggia ogni approccio meccanicistico o superstizioso ai carismi. Non esistono formule magiche per “attivare” lo Spirito Santo; esiste la preghiera e la sottomissione alla volontà di Dio. Il credente maturo sa di dipendere in ogni istante dalla grazia di Dio. Se, per esempio, Dio lo ha adoperato ieri in una profezia, oggi si rimetterà con umiltà in ascolto per capire se e cosa Dio voglia comunicare, senza presumere di poter profetizzare di testa propria. Il dono spirituale non è mai sotto il bottone di accensione dell’uomo, bensì sotto la regia dello Spirito. In questo senso possiamo affermare che la continuità dei carismi non significa uniformità o disponibilità continua: la Kehillah di oggi ha accesso a tutti i doni che lo Spirito vorrà concedere, ma li vedrà manifestarsi quando Dio lo decide, non in modo costante o programmabile.
Lo scopo dei doni: edificazione e bene comune
Un punto fermo, già emerso, è che i doni spirituali hanno sempre una teleologìa, uno scopo intrinseco rivolto al bene degli altri e alla gloria di Dio. La manifestazione dello Spirito è data a ciascuno per l’utilità comune sottolinea Paolo ai Corinzi. Questo principio di utilità comune è il criterio principale per valutare e orientare l’esercizio di ogni carisma. Un dono autentico dello Spirito non sarà mai fine a sé stesso, né concesso per destare stupore sterile o curiosità morbosa: avrà sempre un fine di edificazione, consolazione, incoraggiamento, istruzione o comunque di beneficio spirituale per la comunità dei credenti (1 Cor. 14,3-4). Se tale finalità viene a mancare, è segno che non siamo di fronte a una genuina manifestazione dello Spirito, ma a un artifizio o a un inganno demoniaco!
Paolo dedica ampio spazio, soprattutto in 1 Cor. 12—14, a correggere gli abusi e i fraintendimenti dei carismi nella comunità di Corinto. Alcuni cristiani corinzi tendevano ad enfatizzare i doni più spettacolari (come il parlare in lingue) come status symbol spirituali, causando disordine nel culto comunitario e confusione tra i partecipanti. L’apostolo ricentra il discorso ricordando che la varietà dei doni proviene da un unico Spirito e che, analogamente alle membra di un corpo umano, ogni dono ha la sua funzione complementare per il benessere dell’organismo intero (1 Cor. 12,12-27). Non esistono doni inutili, ma neppure doni destinati all’auto-esaltazione. Paolo arriva persino a preferire, nell’assemblea, poche parole profetiche intelligibili piuttosto che un profluvio di lingue incompresibili, perché ciò che conta è «che la Kehillah ne riceva edificazione» (1 Cor. 14,5). L’edificazione — ossia il far crescere spiritualmente i fratelli e le sorelle, costruendo il loro carattere e la loro fede — è il metro di misura del valore di un carisma in azione.
Parlare in lingue come criterio di salvezza
Fin dagli inizi del movimento pentecostale, sorto agli inizi del Novecento a Los Angeles, nel celebre risveglio di Azusa Street, il fenomeno del parlare in lingue ha assunto un ruolo così dominante da essere elevato a segno distintivo della salvezza stessa. In breve tempo, in alcune correnti, questo carisma venne quasi equiparato a un “sacramento” indispensabile: chi parlava in lingue era ritenuto rigenerato e battezzato nello Spirito, mentre chi non lo faceva veniva guardato con sospetto, come se la grazia di Dio non fosse realmente operante in lui. Così il dono delle lingue, che la Scrittura presenta come una delle molteplici manifestazioni dello Spirito (pneumatika), è stato trasformato in condizione assoluta, posto sullo stesso piano della grazia salvifica nel Messia (Ef. 2,8-9). In questa logica distorta, la formula implicita diventa: «Salvati non soltanto per grazia mediante la fede, ma anche per la prova tangibile del carisma».
Ma questa concezione non solo è ingenua: è pericolosa. Perché? Perché capovolge l’Evangelo e rischia di condurre più anime alla perdizione che alla salvezza. La Parola di Dio è inequivocabile: la salvezza non dipende da alcun segno carismatico, ma unicamente dall’opera compiuta di Yeshua e dalla fede in Lui (Rom. 3,28; Tt. 3,5). Nessun passo della Scrittura insegna che le lingue siano requisito per essere riconosciuti figli di Dio. Anzi, Paolo sottolinea chiaramente che non tutti parlano in lingue (1 Cor. 12,30), eppure tutti i credenti sono partecipi della stessa grazia. Ridurre la certezza della salvezza a un’esperienza carismatica significa sostituire il fondamento della croce con un criterio umano.
La Bibbia, piuttosto, insegna che ciò che autentica un vero credente salvato per grazia non è il possesso dei doni, ma la presenza dei frutti dello Spirito (Gal. 5,22-23). Altrimenti, dovremmo pensare che chi ammette, anche pubblicamente, di non avere doni specifici sta implicitamente ammettendo di non essere salvato! Yeshua stesso ammonì: «Dai loro frutti li riconoscerete» (Mt. 7,16-20), non "dai loro doni o segni". È l’amore, la gioia, la pace, la pazienza, la bontà e la fedeltà che dimostrano se un cuore è stato veramente trasformato, non il parlare e/o pregare in lingue. Confondere i segni con i frutti è un inganno sottile, perché i segni possono essere falsificati (Mt. 7,22-23), ma il frutto autentico della nuova nascita non può essere imitato senza una vera rigenerazione.
Ecco perché l’insegnamento che subordina la salvezza al dono delle lingue non è solo erroneo: è un altro Vangelo (Gal. 1,6-9). È un fardello che Dio non ha mai imposto, e che rischia di gettare nella disperazione coloro che, pur essendo salvati per grazia, non sperimentano un determinato carisma. La verità biblica resta inalterata: siamo salvati soltanto per grazia, mediante la fede, e non per un dono carismatico (Ef. 2,8-9). I doni sono strumenti dello Spirito per l’edificazione della Kehillah (1 Cor. 12,7), ma i frutti sono la vera prova che lo Spirito abita davvero in noi.
Un elemento inscindibile dallo scopo edificativo è l’amore cristiano (agàpe). 1 Cor. 13, l’inno all’amore, non è un capitolo isolato ma è incastonato proprio tra i capitoli sui carismi. Questo collocamento è intenzionale: Paolo insegna che anche i doni più straordinari — lingue degli angeli, profezia, fede miracolosa, generosità eroica, persino il martirio — non hanno alcun valore agli occhi di Dio senza l’amore (1 Cor. 13,1-3). L’amore è l’ambiente in cui i carismi devono operare, altrimenti essi diventano suono vuoto. Il frutto dello Spirito (Gal. 5,22-23), primariamente l’amore che non cesserà mai, ha la precedenza sui doni dello Spirito. I carismi sono strumenti, l’amore è la motivazione e il fine ultimo. Se un presunto dono alimenta la vanità o la rivalità, possiamo dubitare che provenga davvero dallo Spirito Santo, poiché lo Spirito promuove sempre l’unità nell’amore (Ef. 4,3-4) e il bene comune.
Pertanto, ogni qualvolta crediamo che lo Spirito stia manifestando un carisma, dobbiamo domandarci: qual è lo scopo utile? Chi viene aiutato, edificato, servito da questa manifestazione? Si tratta di promuovere la fede? Di alleviare una sofferenza? Di confermare la verità del Vangelo ai non credenti? Di guidare la Kehillah in una decisione? Se non è chiaro un fine positivo, c’è motivo di sospendere il giudizio e attendere. Dio non disperde i Suoi doni in modo caotico o privo di senso; al contrario, Egli è un Dio d’ordine, non di confusione (1 Cor. 14,33).
Storicamente, ogni risveglio spirituale o stagione di rinnovamento nella Kehillah è stato accompagnato da manifestazioni carismatiche con scopi precisi. Per esempio, agli albori della missione cristiana, Dio confermava la predicazione degli apostoli «con segni e prodigi» (Mc. 16,20; At. 14,3) – guarigioni, liberazioni, miracoli – affinché i cuori dei non credenti fossero aperti al messaggio del Messia. I segni presentati nella Bibbia servivano dunque non per intrattenere ma a dare forza e credibilità all’annuncio del Vangelo in un contesto pieno di superstizione e magia (si pensi ai pagani abituati agli incantesimi: Dio mostrava che la potenza del Suo Spirito superava qualsiasi magia umana). Allo stesso modo, nella Kehillah radunata, una profezia autentica può servire a toccare il cuore di tutti e portare ravvedimento (1 Cor. 14,24-25), o un dono di insegnamento può illuminare le menti sui misteri di Dio. I nove doni dello Spirito che vengono concessi alla Kehillah devono avere un loro fine: noi sappiamo che Dio, in tutte le Sue opere, evita l’inutile e vuota ostentazione di potenza. Questa verità ci ricorda che Dio non compie mai miracoli per spettacolo o per capriccio: c’è sempre una ragione di grazia dietro ogni Suo intervento. Il credente dotato di discernimento e sobrietà saprà dunque cercare quella ragione e cooperare con lo Spirito in vista di essa, senza lasciarsi prendere dalla mera ricerca del sensazionale.
Inoltre, lo scopo comunitario implica che i carismi debbano operare entro i limiti dell’ordine e della sottomissione reciproca. Paolo regola, per esempio, che anche i profeti, pur ispirati, debbano parlare uno per volta e gli altri giudichino, e «lo spirito dei profeti è sottoposto ai profeti» (1 Cor. 14,29-32). Ciò insegna che l’esperienza carismatica autentica non porta mai fuori controllo né rende chi la vive incapace di autocontrollo; al contrario, proprio perché finalizzata al bene comune, si integra armoniosamente nella vita della comunità, rispettandone la pace e l’edificazione ordinata. Quando l’esercizio di un presunto dono (o una strana idea su di esso) genera confusione, scompiglio o addirittura divisione, è segno che qualcosa non va: o la modalità è sbagliata, o la fonte non è quella genuina.
Uso corretto dei carismi vs. abusi e falsificazioni
Alla luce di quanto detto, possiamo delineare i tratti dell’uso corretto dei doni spirituali e, per contrasto, riconoscere gli abusi o le false manifestazioni. Un uso corretto dei carismi avviene quando i credenti, pieni di Spirito Santo, esercitano i doni con umiltà, in obbedienza alla Parola di Dio, per edificare gli altri e glorificare il Messia piuttosto che per atterrire e demolire gli altri. In tal caso, i doni non alimentano orgoglio né rivalità, anzi spingono chi li esercita a riconoscere la propria piccolezza e la grandezza di Dio che opera attraverso di lui. Spesso chi è davvero usato nei carismi tende a minimizzare sé stesso e a esaltare il Signore, dicendo con sincerità: «Siamo servi inutili; abbiamo fatto ciò che dovevamo fare» (Lc. 17,10).
Al contrario, qualunque utilizzo soggettivistico e individualistico dei carismi è sintomo di deviazione. Se qualcuno pretendesse di usare un dono per vantaggio personale — sia esso prestigio, lucro o potere — starebbe tradendo la natura stessa del dono. Come affermato, i doni non sono dati a beneficio di chi li riceve, ma per l’utilità del popolo di Dio. Quando un cosiddetto “carisma” serve ad affermare sé stessi, ad alimentare un culto della personalità o a creare dipendenza dalla propria figura, c’è da dubitare fortemente che si tratti di un autentico dono dello Spirito. Può trattarsi di esibizionismo, autosuggestione o peggio. La storia della Chiesa offre purtroppo esempi di predicatori o leader che hanno fatto leva su presunti poteri spirituali per manipolare le folle o arricchirsi: tali pratiche sono una falsificazione dei carismi autentici, una profanazione di ciò che viene da Dio.
Abbiamo già menzionato il caso di Simone il mago come archetipo dell’atteggiamento sbagliato: voler possedere il dono per usarlo a proprio uso e consumo. Un altro esempio biblico di abuso è la kehillah di Corinto stessa: alcuni dei corinzi usavano il parlare in lingue in modo caotico e auto-centrato, forse per mettersi in mostra come i Farisei ai quali piaceva pregare in pubblico e dare l'apparenza della pietà e devozione, tanto che Paolo dovette correggerli severamente (1 Cor. 14). Egli insegnò che se non c’è interprete, il dono delle lingue deve tacere nell’assemblea, perché «Dio non è un Dio di confusione, ma di pace» (1 Cor. 14,33). Ciò mostra che l’autentico carisma non rende la persona una fanatica incontrollabile; se uno insiste a manifestare qualcosa incurante del contesto e dell’effetto sugli altri, sta usando in modo improprio (o molto più probabilmente fingendo) il dono. Lo Spirito Santo mai sospinge al disordine o all’egocentrismo. Dove c’è lo Spirito, c’è libertà (2 Cor. 3,17) ma non anarchia; c’è potenza ma anche dominio di sé (2 Tim. 1,7).
Un segnale di falsificazione è anche il sensazionalismo fine a sé stesso: cercare continuamente il miracolo, la manifestazione straordinaria, quasi per brivido spirituale o per sentirsi speciali. Yeshua stesso ha messo in guardia da questo atteggiamento:
Molti mi diranno in quel giorno: "Signore, non abbiamo noi profetizzato in nome tuo e cacciato demoni e fatto molte opere potenti nel tuo nome?" Ma io dichiarerò: "Non vi ho mai conosciuti” (Mt. 7,22-23)
Ciò implica che si possono perfino fare gesti prodigiosi esteriormente, eppure non essere nel centro della volontà di Dio né avere una vera relazione con il Messia. Quel «non vi conosco» è spaventoso: indica che prodigi senza ubbidienza e amore non provano nulla circa la santità o salvezza di una persona: vantarsi, per esempio, di parlare in lingue ogni giorno, non significa che sei automaticamente salvato! D’altronde, il Tanakh e le Scritture Apostoliche avvertono che falsi profeti e impostori possono compiere segni ingannevoli (Deut. 13,1-4, 2 Tess. 2,9-10). Come discernere allora? Yeshua disse: non dai segni, ma «dai loro frutti li riconoscerete» (Mt. 7,20). Il frutto è il carattere, l’amore, la fedeltà a Dio, l’edificazione reale, il modo pacato di esprimersi, una mente non violenta né guerrafondaia. Un «dono» ostentato con arroganza, accompagnato da vita immorale o da avidità, o dalla presunzione di essere più maturi e adulti di altri, non è un dono che viene dallo Spirito Santo, per quanto spettacolare possa sembrare. Non bisogna confondere il carisma con il carismatico di facciata. Meglio una kehillah locale sobria ma piena di amore, che una assemblea piena di fenomeni e messe in scena ma priva di santità e di compassione.
Dal lato opposto, l’abuso può consistere anche nel trascurare o soffocare i doni. Se Dio ci ha realmente affidato un carisma, Egli si aspetta che lo impieghiamo. Ricordiamo la parabola evangelica dei talenti (Mt. 25,14-30): il servo che nasconde il talento ricevuto e non lo fa fruttare viene definito malvagio e negligente. Pur riferendosi a doti e responsabilità in senso lato, la parabola suggerisce che non usare ciò che Dio ci ha dato è un fallimento di fedeltà. Paolo esorta Timoteo a «ravvivare il dono di Dio» che era in lui (2 Tim. 1,6), e in un altro passo dice: «non trascurare il dono che è in te» (1 Tim. 4,14). Dunque l’altra faccia della medaglia è: se abbiamo ricevuto un dono spirituale, non dobbiamo né sopprimerlo per paura degli uomini, né tergiversare, ma impiegarlo con coraggio per il bene di tutti. L’errore contrario sarebbe razionare l’opera dello Spirito per eccesso di prudenza umana o incredulità. La via equilibrata sta nell’avere uno zelo aperto ai carismi («desiderate ardentemente gli πνευματικά [pneumatikà, operzioni dello Spirito]», 1 Cor. 14,1) unito a un esercizio regolato dall’amore e dalla verità biblica.
Possiamo quindi riassumere alcuni criteri pratici:
- L’esercizio legittimo dei doni spirituali avverrà in sottomissione alla Scrittura, in comunione con la Kehillah (sottoposto anche al giudizio comunitario, come nel caso della profezia in 1 Cor. 14,29), con uno spirito di servizio e per scopi che onorano Dio. In tale contesto, i carismi portano benedizione, unità e crescita.
- Al contrario, un esercizio indipendente, volto all’auto-promozione o contrario ai principi biblici, produrrà divisione, spiritualità individualistica o antropocentrica (tutto ruota intorno a me), confusione o inganno – segno che non è opera dello Spirito Santo, ma della carne o peggio.
Come affermato, qualunque utilizzo soggettivistico e individualistico dei carismi non è l’espressione dei carismi, ma solo falsificazione di quello che in realtà non si è ricevuto da Dio. Questo ci ricorda che se qualcuno usa in modo egoistico un supposto dono, probabilmente quel dono non l’ha ricevuto da Dio affatto. Può essere illusione o frode, simulazione o auto-inganno. I veri carismi, invece, convergono sempre sul bene comune e sulla glorificazione del Messia come Signore.
Conclusioni
In conclusione, dalla nostra analisi emerge con chiarezza che il dono spirituale biblico non va inteso come un regalo di cui l’uomo diventi proprietario, bensì come una grazia che Dio concede liberamente e mantiene sotto la Sua Signoria. La gratuità del dono non implica un trasferimento di proprietà, ma l’assenza di merito da parte nostra e la generosità sovrana da parte di Dio. Egli affida i Suoi doni ai credenti come strumenti di servizio, richiedendo loro fedeltà e umiltà nell’amministrarli. I doni non ci appartengono — appartengono allo Spirito Santo — e perciò non possiamo usarli in modo capriccioso o egoistico senza tradirne la natura.
Al contrario, siamo chiamati a metterli a frutto per l’utilità comune, lasciandoci guidare dall’amore. I carismi autentici non faranno di noi dei “super-uomini” che spadroneggiano su poteri mistici; faranno di noi, semmai, dei servitori più efficaci, canali attraverso cui la grazia di Dio fluisce verso altri nei momenti e nei modi che Egli stabilisce. Ogni volta che Dio ci userà in un dono — sia nel parlare con sapienza, nell’incoraggiare con una profezia, nell’impartire guarigione o qualsiasi altra manifestazione — ricordiamoci della sorgente: «Che hai tu che non l’abbia ricevuto?» (1 Cor. 4,7). Questa domanda retorica ci immunizza dall’orgoglio. Se tutto è ricevuto, allora a Dio soltanto va la gloria, e a noi la gioia di cooperare al Suo piano.
Invito dunque ogni lettore, e ogni comunità cristiana, a discernere alla luce della Parola il vero significato di dono spirituale. Occorre rigettare risolutamente sia la concezione mercantilistica o magica (il dono-regalo da possedere, comprare o esibire) sia l’idea passiva di un dono inutilizzato e sepolto. Piuttosto, abbracciamo la visione biblica: i doni come espressione multiforme della grazia di Dio, da accogliere con gratitudine e da esercitare con responsabilità. Chiediamoci in preghiera quali carismi lo Spirito abbia posto nelle nostre vite e nelle nostre assemblee, e come possiamo «metterli a servizio degli altri, come buoni amministratori della grazia di Dio» (1 Pt. 4,10). Questo implica sia disponibilità a farsi usare (vincendo timidezze e paure umane), sia sottomissione nell’uso (evitando ogni deriva di orgoglio o disordine).
Infine, teniamo sempre presente il telos, cioè il fine ultimo: l’edificazione del Corpo del Messia e la testimonianza dell’amore di Dio nel mondo. Quando i doni spirituali operano secondo il disegno divino, la Kehillah ne esce arricchita e il nome del Signore è esaltato. Ciascun credente, nel suo piccolo, può contribuire a questo bene comune usando i doni ricevuti — piccoli o grandi che siano — con lo spirito giusto. La sfida pratica che lanciamo è duplice: da un lato, non spegnere né disprezzare le manifestazioni autentiche quindi bibliche dello Spirito (1 Tess. 5,19-20), anzi desiderarle e coltivarle; dall’altro, vigilare sempre sul proprio cuore affinché rimanga umile e centrato su Yeshua, fonte di ogni dono.
In un’epoca in cui si rischia di oscillare tra scetticismo verso il soprannaturale e credulità acritica verso ogni pretesa manifestazione per sete di sensazionalismo, il credente deve tornare alla Bibbia e all’equilibrio che essa insegna. Dio è ancora il Datore generoso di doni spirituali, e la Kehillah ha bisogno di questi carismi vivi; ma essi sono e rimangono doni, non possessi. Se ne faremo esperienza, ricordiamo di restituirne subito la gloria al Signore e di condividerne il frutto con i fratelli. Così facendo, i doni spirituali compiranno davvero il loro scopo: edificare la comunità nella fede e rendere tangibile la grazia di Dio nel nostro tempo, senza mai usurpare il posto del Donatore. Il dono è sempre Suo — a noi la gioia di esserne soltanto i canali fedeli.
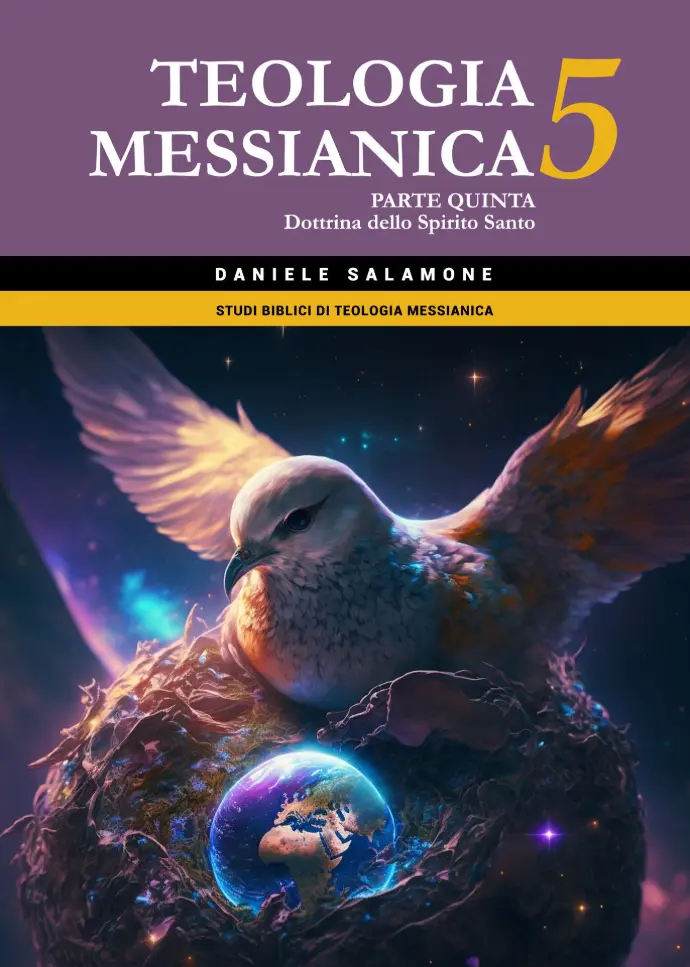
Se desideri approfondire la Pneumatologia, ti invitiamo a iscriverti alla Yeshivah e a seguire il nostro Corso dedicato di 25 ore.
In alternativa, puoi trovare su Amazon il quinto volume della nostra Teologia Messianica, intitolato Dottrina dello Spirito Santo.
Scopri di più